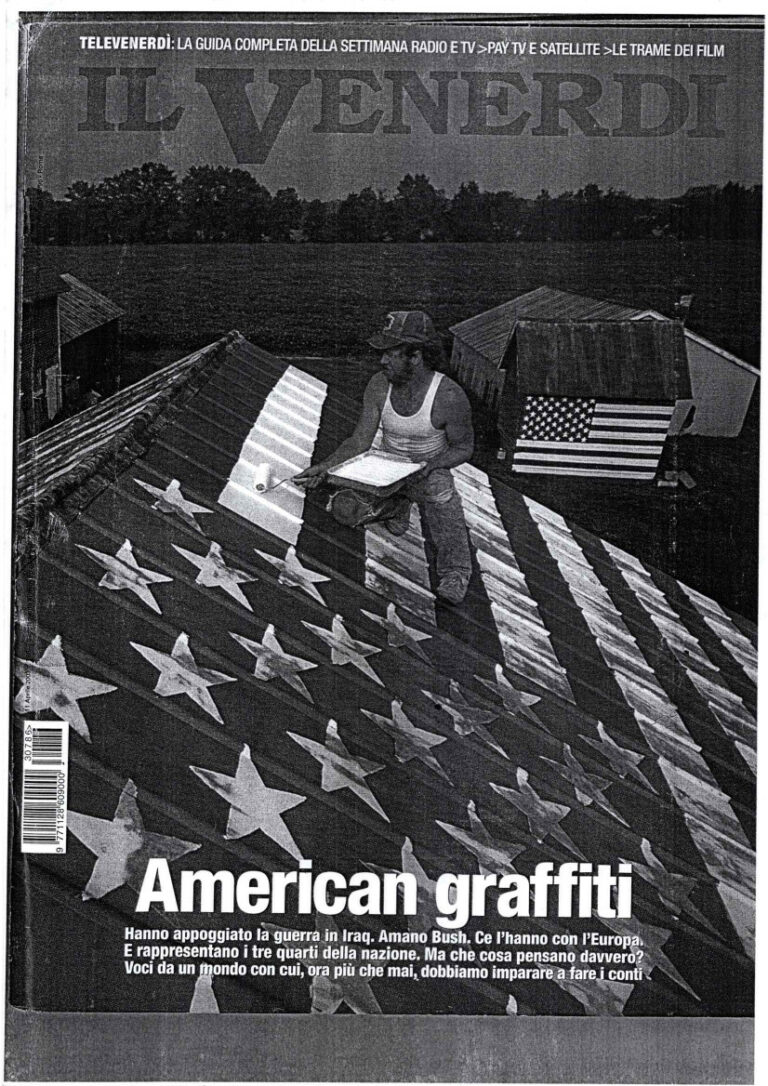Marciavano su Roma. E il bombardamento di San Pietro Infine diventò una strage: un paese cancellato. Ma allora perché la sua storia è stata rimossa fino ad oggi? La Bagdad dimenticata d’Italia «Noi, uccisi e liberati dagli Usa»
Nella valle del fiume Liri c’è una Bagdad dove tutto è già successo sessant’anni fa. San Pietro Infine: paese raso al suolo dalle bombe dei liberatori. Mai più ricostruito. Dimenticato da tutti. Meno che dai suoi bambini di allora: i suoi vecchi di oggi. «Ecco, era qui che abitavo io»: Domenico Di Zazzo, 71 anni, ferma i passi lenti davanti a un perimetro di pietre diroccate. «Proprio qui, davanti al barbiere, c’era la mia finestra». Ma il portone del barbiere è uno scheletro che si apre su un intrico di sterpaglie, e la finestra di Menicuccio esiste solo nel gesto quadrato che le sue dita tracciano nell’aria battuta dal Serpentone, il cugino della bora, il vento che fa urlare le montagne.
«È venuto a vedere la nostra El Alamein?», domanda Pasquale Ferri, ottant’anni. Salgono spesso a San Pietro vecchia i vecchi di San Pietro, caracollando con i bastoni su dal paese nuovo, ricostruito un chilometro più a valle nel ’49. Ma per tanti anni anche loro non vollero più tornarci: «Batteva troppo il cuore». Non c’è famiglia che non abbia lasciato almeno uno dei suoi cari tra queste viuzze tutte scale, non c’è famiglia che non abbia perso tutto nei 10 giorni dell’inferno di ferro e di fuoco, dall’8 al 17 dicembre del 1943, quando gli Alleati sbucarono laggiù, sotto al Montelungo, e trovarono i tedeschi ben preparati ad accoglierli sul monte Sammucro.
La cocciutaggine del generale Clark, forse la sua fretta di arrivare a Roma, costarono cari: dieci giorni di battaglia, per due chilometri, per milleduecento morti, per arrivare dove? Nella piana di Cassino, dove un’altra carneficina aspettava il suo momento.
Ci sono voluti sessant’anni per trovare il coraggio di scavare nel terriccio e nella memoria. «Sembra di stare a Pompei, vero?», sussurra Paolo Vacca, architetto, che ci fa da cicerone tra le stradine selciate di candida dolomia, strade di un borgo che fu ricco, crocevia tra Campania, Lazio e Molise, sedici frantoi sempre in attività, capitale dell’oliva liciniana, la migliore dell’impero romano. Un gruppo di donne scava, pulisce, diserba: sono operaie della Comunità montana. Le guida Anna Maria Nardelli, che fin da bimba frugava tra le rovine: «Non sono un’archeologa, ma ogni pietra che tiriamo fuori è un’emozione». Le manda Fabio Vecchiarino, da sei mesi sindaco di San Pietro, da anni ossessionato dall’idea di restituire la Storia al suo paese: «Per troppo tempo questo è stato un luogo di dolore e rimozione. Ora deve diventare un luogo che ricordi a tutti l’orrore della guerra». Vuole il Parco della memoria, spera nel timbro dell’Unesco, intanto fa pulire, attrezzare, piantare cartelli.
«La battaglia di Montecassino la ricordano tutti. San Pietro è sparita dalla memoria degli italiani». Anche da quella dei governanti: per San Pietro, tre anni fa, solo una medaglia d’argento. Per i vecchi quasi un’offesa: «Perché a Mignano la medaglia d’oro?». Perché a Mignano c’è il cimitero di guerra. «E questo», Antonia Fuoco abbraccia il paese fantasma su cui veglia la cupola sbrecciata di San Michele Arcangelo, «non è un cimitero? Se lo sono dimenticati tutti…».
Gli americani no, se lo ricordano benissimo. Perché John Houston, allora in divisa, girò tra queste rovine The Battle of San Pietro, quaranta minuti presi praticamente in diretta, uno dei documentari più duri della Seconda guerra mondiale, così duro che i generali di Washington abbandonarono la sala indignati alla prima proiezione, così duro che Spielberg lo prese a modello per le scene più sconvolgenti del suo Soldato Ryan. Così, ora, gli americani sono di casa a San Pietro più degli italiani. Un signore di Chicago, Herman Chanowitz, a 88 anni è cittadino onorario del paese. Era un «liberatore», capitano yankee sbarcato a Salerno con la V Armata, addetto ai collegamenti con i bombardieri: «ero io a dirgli dove sganciare». Rimorsi? «Ai commilitoni con cognomi italiani chiedevo: se le bombe finiscono sui vostri nonni? Speriamo di no, rispondevano, e non c’era verso di cavargli altro».
Speravano di no, e invece era sì. San Pietro sembrava un paese disabitato: non lo era. «I tedeschi ci avevano avvertito: raus, qui fra pochi giorni diventa un macello. Ma chi si fidava di salire su un camion tedesco?». Rimasero in cinquecento. Meo Antonio fu Filippo ebbe l’idea per primo: prese la vanga e si scavò una grotta nel tufo friabile di un vallone riparato, dentro lo sperone di roccia su cui sorge il paese. Gli altri seguirono l’esempio. In cinque giorni il paese scese nelle catacombe della paura.
«Niente cibo, niente acqua, niente aria». Antonio Di Zazzo chiude gli occhi. «Il mio fratellino di un anno piangeva per la sete. C’era solo l’acqua sporca che colava dalle pareti. Quando morì, la sua bara fu una cassa per munizioni». Poche decine di metri di terra più su le cannonate demolivano case e cose. «Solo all’alba c’era una tregua: qualche donna usciva per cercare l’acqua». Nella cisterna del paese i tedeschi avevano buttato la carogna di un asino. Bisognava andare più in là, allo scoperto. Rosa Fuoco aveva vent’anni e molto coraggio: stava tornando con un bottiglione in bilico sulla testa, quando una vedetta americana, dall’altra parte della valle, la avvistò. «Forse il luccichio del vetro gli sembrò quello di un proiettile». La precisione chirurgica del tiro esisteva già allora, ma è la precisione delle decisioni umane che nessuno ha mai inventato: Rosa morì davanti alla chiesina di San Sebastiano, centrata dal fumogeno di puntamento prima ancora che, seguendo il fumo, una valanga di proiettili d’artiglieria uccidesse un’altra decina tra donne e ragazzi.
Centotrentacinque morti per 1412 abitanti: un paese decimato. Solo 14 li fucilarono i tedeschi: tutti gli altri se li portò via il Conqueror, l’artiglieria degli alleati. Paradossi della guerra: i nazisti oppressori avevano cercato di salvare il paese sfollandolo, gli americani liberatori l’avevano condannato a morte. «Ci hanno liberato, ci hanno ammazzato», dicono i vecchi, ma il rancore che ti aspetteresti non c’è. «Abbiamo mille ragioni per non odiare gli americani», ti spiega Giovanni Di Florio, allora undicenne, «ci spararono addosso, è vero, ma poi ci nutrirono, ci lavarono, ci disinfettarono…». «Salutavano ellò paisà, regalavano caramelle, sigarette…». «A me una sottoveste…»: Emilia Colella se la ricorda ancora la sua «vestina» nuova, e ride, però in questi giorni, quando c’è il tg, lei spegne la tivù. «Non auguro a nessuno di passare quel che abbiamo passato noi, quei poveretti laggiù mi fanno pena». Quelli laggiù, i bambini di Bagdad. «Non deve mai più accadere. La politica, prima della guerra», ripete Di Florio. Un paese che ama gli americani. Un paese che odia la guerra.
Su uno schermo, a casa del sindaco, scorrono immagini inedite del film di Houston. Ritratti immobili, quasi fotografici, dei bambini di San Pietro appena usciti dalle caverne della «valle della morte». «Anch’io ho combattuto quella battaglia», dice a se stesso Adriano Vecchiarino, lo zio del sindaco, che allora aveva 5 anni, «ma nella condizione più sleale: tutti avevano le armi, io no. Io potevo solo subire».