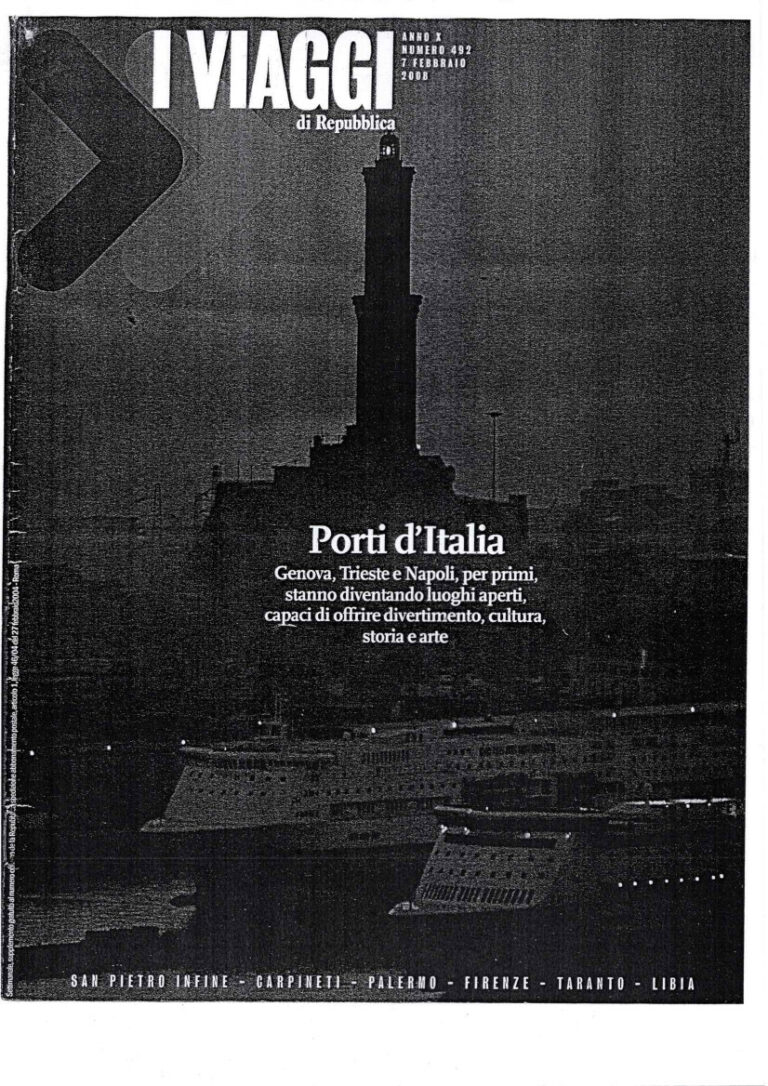Quando si spensero le luci, il buio nella sala proiezioni del Pentagono era simile all’oscurità delle notti d’inverno sul fronte italiano. In quell’oscurità, le stellette dei generali venuti per l’anteprima del documentario brillavano come le stelle che il soldato osserva preoccupato sapendo che domani farà bel tempo e la battaglia tornerà a infuriare.
Ad un terzo del film, fu un generale di brigata il primo ad alzarsi e ad avviarsi verso l’uscita. Ad uno ad uno, tutti gli ufficiali si alzarono e se ne andarono. «Alla fine mi ritrovai solo nella sala» raccontò in una intervista l’autore del film, il grande regista John Houston. Inviato al seguito delle truppe americane in Italia durante la Seconda guerra mondiale, con l’incarico di girare un documentario di propaganda, realizzò quello che viene considerato il più bel combat film della storia del cinema: La battaglia di San Pietro.
San Pietro Infine si trovava in un punto cruciale della strada che da Napoli porta a Roma e, mentre le retrovie germaniche approntavano una linea di difesa più munita e potente tra Cassino e le Mainarde, la linea Gustav, gli ufficiali ricevettero da Berlino l’ordine di tenere a tutti i costi il paese e la montagna sovrastante. Gli americani avevano lo stesso ordine, ma inverso: sfondare il fronte, superare Cassino e marciare verso Roma.
Alla fine dello scontro, durato più di dieci giorni, sul campo rimasero almeno 1100 soldati americani, 300 civili italiani ed un numero imprecisato, ma sicuramente elevatissimo, di tedeschi. Questa era la guerra: fanti che strisciano nel fango dopo due settimane di pioggia continua, colpi di cannone, spari, cadaveri sparsi ovunque, l’improvvisato cimitero. E questo Houston raccontò nel suo film, che fu rifiutato: «Mi fu detto da un portavoce che il film era contro la guerra. Io replicai che se mai avessi fatto un film a favore della guerra speravo che qualcuno mi fucilasse. Il tipo mi guardò come se stesse meditando di farlo davvero», scrisse il regista nelle sue memorie. Solo grazie all’intervento del generale Marshall il documentario ricevette l’autorizzazione alla diffusione.
Oggi La battaglia di San Pietro rimane una preziosa ed emozionante testimonianza di una vicenda dolorosissima, che vide coinvolti anche i soldati italiani (da poco passati con gli Alleati), che nello scontro ebbero molte vittime (a loro è dedicato il sacrario di Montelungo, sulla Casilina), e soprattutto gli abitanti di San Pietro Infine, che per sopravvivere dovettero rifugiarsi in grotte scavate in un canalone prossimo al paese, sopravvivendo senza cibo né acqua.
Visitare oggi quelle gallerie, in cui occorre camminare curvi, nella penombra, lascia interdetti, ma anche affascinati dal pensiero che di fronte a difficoltà che sembrano insormontabili, la forza della disperazione rende gli uomini più forti e determinati. Quando il 17 dicembre 1943 (cade quest’anno il 65° anniversario) i primi soldati americani entrarono a San Pietro, non c’erano che cumuli di macerie. Da allora tutto è rimasto così: è uno dei pochissimi paesi a non essere stato ricostruito nel luogo in cui sorgeva prima delle devastazioni della guerra.
Non a caso, Monicelli decise di girare proprio qui alcune scene de La Grande Guerra, con Sordi e Gasmann. Il vecchio borgo è oggi un Parco della Memoria, appena aperto al pubblico (© 0823-1681551-348-7168098), dotato anche di un moderno Centro visita realizzato dalle Officine Rambaldi: «Ci siamo posti il problema di come valorizzare quanto rimaneva dell’antico borgo, un luogo simbolico, carico di emozioni», racconta Maria Antonietta Di Florio, responsabile del Parco: «Non era facile intervenire in un contesto del genere, ma nemmeno volevamo che il tempo distruggesse quanto era stato risparmiato dalle bombe».
Tra gli abitanti c’è anche chi avrebbe preferito dimenticare, guardare avanti e far finta che quei muri smozzicati, quelle pietre divelte e spezzate siano da lasciare al loro destino. Ma ha prevalso l’idea di utilizzare il borgo medioevale per dare una testimonianza dell’assurdità della guerra e «per creare un luogo che serva da volano per una economia basata sul turismo: un turismo intelligente, che non cerca l’evasione, ma l’emozione, la profondità dell’esperienza», conclude Maria Antonietta.
La valle sottostante, attraversata dall’antica Via Casilina, che gli americani avevano rinominato Death Valley, potrebbe diventare non più un punto di passaggio di eserciti, come è stato per millenni (per questo già i Sanniti si diedero da fare per munire il Monte Sammucaro e la cima del monte Frascara, sul Vulcano di Roccamonfina, di fortificazioni dalle possenti mura megalitiche), ma la via di accesso ad un territorio affascinante, tra il vulcano di Roccamonfina ed il Matese, dove nord e sud d’Italia si toccano.
Non è un caso che proprio qui, il 26 ottobre 1860, nella campagna tra Vairano Patenora e Teano, Vittorio Emanuele si incontrò con Garibaldi, saldando i due pezzi del Regno. Ma questo è un territorio che non guarda solo al passato, anche se cerca di non dimenticarlo, ma che sta cercando di sfruttare le potenzialità che possiede: dall’enogastronomia all’escursionismo, dall’archeologia allo sport.
Nel territorio di Presenzano, nel bacino inferiore di una delle più grandi centrali idroelettriche d’Italia, il due volte oro olimpico di canottaggio Davide Tizzano prepara i campioni di domani nel suo Centro Nautico ENEL (© 0823.989008–338.8031753). Grazie all’impegno di Davide, anche il fiume Volturno è stato reso fruibile agli sportivi che amano le discese in canoa, in un ambiente intatto.
In molti paesi della zona, i cui centri storici stanno conoscendo interessanti progetti di recupero, si punta alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, che sono molti e di alta qualità. È una sfida da vincere, anche per dimostrare che esiste un’altra Campania, che non finisce quotidianamente nei telegiornali per i morti ammazzati dalla Camorra o per i rifiuti in strada, ma che lavora, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, per costruirsi un futuro diverso. Tutto da scoprire.